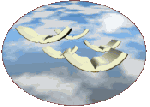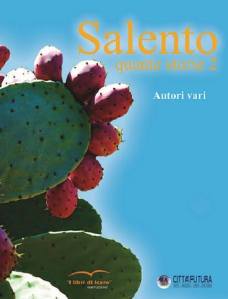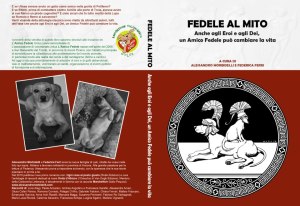Ho tirato oltre la mezzanotte per finirlo. Non vedevo l’ora di arrivare al punto, scoprire le ultime carte e ricostruire tutta la storia alla luce di chiarimenti che sentivo essermi dovuti. Così ho affrontato ansiosa l’ultima pagina, dopo una feroce battaglia con il sonno, che voleva avere la meglio sui miei occhi per chiuderli definitivamente alla fine di una lunga e pesante giornata. Giunta all’ultimo rigo, all’ultimo punto, ho scoperto che… che non ci ho capito niente.
Del resto me la sono cercata.
Peter Høeg è notissimo per il suo primo best seller, “Il senso di Smilla per la neve”. Romanzo meraviglioso, il primo che mi ha fatto innamorare della schiera degli scrittori nordici, scandinavi e giù di lì. Høeg è danese per la precisione, ma poco cambia, l’ambientazione è decisamente fuori dagli schemi mediterranei, o americani, cui siamo abituati. Il Nord Europa sembra un luogo a sé. Io non ci sono mai stata ma, del resto, a che serve altrimenti la lettura?
Høeg è stato bravo, mi ha fregata una prima volta e mi ha imbrogliato anche la seconda. Infatti dopo Smilla e il suo senso per la neve avevo letto un altro romanzo, “I quasi adatti”, che mi ha fatto sentire una disadattata io stessa: molta fatica e comprensione scarsa.
Vabbè. Capita di sentirsi inadatti, appunto, a leggere una scrittura così particolare.
Poi, un bel po’ di anni fa, mi imbatto in questo titolo: “La bambina silenziosa”, e mi blocco. Leggo gli strilli che ne anticipano la trama e resto affascinata. Ok, dico, caro Peter, diamoci un’altra possibilità.
Ho acquistato il libro, che poi, per le varie vicende della vita (è uscito nel 2006, credo, io l’ho incontrato qualche anno dopo), è rimasto sulla mia libreria nei secoli dei secoli. Tuttavia, siccome ho fatto un patto con una certa Nera Signora che non deve venire a prendermi fino a che non finisco tutti i libri che giacciono in casa mia a prendere polvere, e poiché sono di parola, dopo un periodo di totale abbandono della lettura (per cause indipendenti dalla mia volontà), ho ripreso a leggere tutto ciò che è rimasto indietro. Certo, non è necessario che la Nera Signora sappia che continuo anche ad acquistare, così che i libri intonsi non finiranno mai: lasciamola lì a fregarsi le mani. E dunque, eccoci qua, con questa bambina silenziosa.
In realtà il protagonista è un quarantenne danese, un circense, un clown per la precisione, con la propensione a vivere pieno di guai, soprattutto tributari, ma con un dono unico: quello di un udito soprannaturale. Kasper non è solo clown, è anche musicista, appassionato soprattutto di Bach, ma lui va oltre il cosiddetto orecchio assoluto. Lui ascolta i rumori di fondo del mondo, spesso paragonandolo a opere sinfoniche e di musica classica. Sente il rumore di ciascuno di noi, delle nostre anime, indovina i nostri pensieri dal suono che fanno, indovina il luogo da cui lo chiama una voce al telefono dopo appena due secondi, percependo suoni riflessi, lontani che nessun umano può recepire. Kasper è un po’ un supereroe, nel senso che ha un super potere. Che poi di questo talento ne faccia buon uso, è tutto da vedere. La sua vita privata è travagliata, ha perso la madre, circense come lui, da bambino, non va d’accordo col padre, che con il circo non ha a che fare, e ha un rapporto complicato con le donne. Ha avuto un grande amore, che sembra finito, ma che si ripresenta per tutto il libro con un ruolo misterioso.
Kasper insegna musica ai bambini e per questo un giorno degli strani personaggi gli portano una bambina, Klara Maria, che non solo non emette rumori di sottofondo (per questo è silenziosa), ma ha il suo stesso dono. Tra i due si instaura un legame, la piccola gli fa sapere di essere in pericolo e lui per tutto il libro cerca di salvare lei e altri bambini uguali a lei, tra personaggi che lo ostacolano e tentano di ucciderlo, altri che lo incoraggiano in segreto, in una baraonda assai poco chiara. Sullo sfondo, una Copenhagen oscura, minacciosa, buia, una città di malaffare con torbidi segreti e sporchi interessi economici da parte di pochi.
Tutto chiaro, vero?
Ecco, ora che ne scrivo, mi pare in effetti di avere azzeccato il senso della storia. È che lo snodo di questa trama è molto più complicato di così. E lo stesso il finale. Il primo impulso che ho avuto, chiudendo il libro e fissando il buio, è stato di rileggere tutto daccapo. Ma era tardi, e ho desistito. Rileggerlo più avanti? Boh, dovrei trattare con la Nera Signora. Sono comunque convinta che a rileggerlo con calma potrei capire meglio. Forse.
Il modus scrivendi è destabilizzante, si passa dal passato al presente, forse anche al futuro e a situazioni oniriche senza linearità. I personaggi sono tanti e non sempre mi sono stati chiarissimi per intenzioni e sentimenti, nemmeno nei nomi. Si parla della capitale danese, dei suoi quartieri, dando per scontato di conoscerli, ma per chi non c’è stato è un bell’incasinamento, non sono descritti in modo classico. E poi riferimenti musicali che chi non conosce la musica classica non sa come collocare.
Conclusione: libro da consigliare? Ni. Ci vuole un po’ di impegno.
Punti a favore:
- sotto sotto c’è anche un thriller che può intrigare, e non è dei peggiori, tutt’altro.
- resta affascinante il dono del super udito, che diventa davvero un super potere il cui uso è descritto benissimo
- Kasper è dopo tutto un vecchio bambino con dei problemi irrisolti, per il quale si può provare tenerezza.
Punti a sfavore:
- la cripticità di cui è ammantata tutta la storia
- il protagonista che a volte ha delle uscite sentite nelle peggiori americanate, o a essere buoni, alla Bud Spencer e Terence Hill. Ma in fondo è un clown, lo è fin nel midollo. Ci sta.
- Certe assurdità, che devi superare con un’opera di fede, come i discorsi della bambina, per fare un esempio, ma non solo
- il finale. Di cui non dico niente.
Però è stato bello incasinarsi nella lettura, vedere se il cervello funziona anche sotto sforzo. E dirsi alla fine: ne voglio ancora.